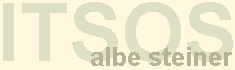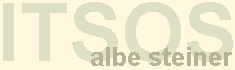DALLA
MEMORIA ALLA FIABA
SAN
DONATO MILANESE SI RACCONTA
Il Comune di San Donato Milanese
ha organizzato, per l’anniversario del riconoscimento da parte dell’ONU
della carta dei diritti del bambino(1),
una serei di manifestazioni culturali e ha chiesto agli studenti dell'ITSOS
di realizzare un CD-Rom.
All'interno di questo progetto
le ragazze e i ragazzi della 2A si sono occupati di ideare e realizzare
alcune interviste a testimoni: ciò è stato il pretesto per
lavorare in generale sulla questione delle fonti ed in particolare sulla
Storia Orale.
I ragazzi hanno poi deciso
di restituire la ricerca sul WEB della scuola.

La
cornice didattica
Il
lavoro si inserisce all’interno della programmazione di Geostoria
del biennio, fondata principalmente sulle seguenti caratteristiche:
A. il curricolo reticolare(2)
che ha le seguenti caratteristiche di fondo:
-
sul piano storiografico
assume quale angolazione prospettica privilegiata la Storia Contemporanea
(XIX° e XX secolo) e più in particolare per quanto riguarda
il Novecento le condizioni dei diversi Nord e Sud del Mondo, alla
luce dei processi attuali di mondializzazione.
-
sul piano didattico,
e più precisamente sul piano dei criteri di organizzazione dei contenuti,
si sposta dall’impianto a moduli, verso un impianto a rete, procedendo
dalle maglie più larghe a quelle più fitte. Ciò significa
che la scelta e il criterio degli argomenti inseriti nel curricolo seguono
tre condizioni:
-
gli argomenti iniziali
saranno quelli che comportano un numero relativamente ristretto di concetti-chiave
(i temi a maglie larghe) e quindi più semplici, ad esempio l’U.D.B
sulle diverse proiezioni cartografiche; gli ultimi argomenti saranno i
più complessi e saranno quelli che richiedono un maggior numero
di concetti-chiave (i temi a maglie più fitte) ad esempio i “recenti”
processi di mondializzazione.
-
rispetto al problema delle scale
spaziali, per quanto l’impostazione sia particolarmente vicina alla
World History, si fa attenzione a presentare dei diversi argomenti una
pluralità di scale, passando da quelle planetarie, a quelle europee
e soprattutto nazionali.
-
Anche per quanto riguarda la
questione delle scale temporali, si privilegiano argomenti legati
a dinamiche di lunga durata, argomenti intesi come cornici, che dovrebbero
rendere possibili approfondimenti (spesso di tipo laboratoriale) su temi
e sotto-temi di durata più breve. In particolare il metodo (favorito
anche dal particolare libro di testo) si fonda sulla presentazione di un
argomento osservato nelle sue linee generali nel presente, studiato alle
sue origini e nel suo svolgersi nel passato, pensato, attraverso momenti
di riflessione, per quanto riguarda il futuro. In questo modo si evita
il rischio che lo studio della Storia Contemporanea sia inteso come studio
del presente, cioè si evita il rischio di scadere nell’eventografia,
se non addirittura nella cronaca.
B. Il laboratorio
di storia, individuato come momento indispensabile e qualificante all’interno
dell’attività curricolare.
Una sperimentazione dell’insegnamento
della storia che fa quindi regolarmente ricorso (non in modo straordinario)
ad attività laboratoriali tese a favorire – attraverso tecniche
didattiche di tipo costruttivista – un apprendimento della storia
basato non solo attraverso la conoscenza dei fatti e degli avvenimenti,
ma soprattutto grazie ad un operare in prima persona da parte degli studenti
sia attraverso il metodo della ricerca didattica che della didattica per
progetti.

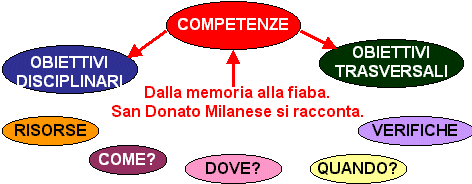

|
La
rappresentazione del pianeta
1 La rappresentazione cartografica
- La proiezione
Mercatore
- La proiezione
Peters
2 La rappresentazione statistica
- Gli indicatori
socioeconomici
Materiali:
Filmati,
lucidi, fotocopie,
carte
geografiche. |
I
Nord e i Sud del Mondo
1 La fine del concetto
di Terzo Mondo
2 I diversi Sud del Mondo
3 Il divario tra i Nord e
i Sud
Materiali:
Manuale,
filmati, CD-Rom, lucidi. |
|
Migrazioni
1 La questione oggi
2 Gli spostamenti umani:
per
tipologia e
nel corso della storia
Materiali:
Manuale,
filmati, lucidi, fotocopie,
carte
geografiche, grafici,
CD-Rom,
interviste. |
La
questione demografica
1 La questione oggi
2 L’andamento demografico
nel corso della storia
3 Demografia, risorse e sviluppo
Materiali:
Manuale,
filmati, lucidi, fotocopie,
carte
geografiche, grafici. |
|
La
questione delle risorse
1 La questione ambientale
2 La produzione alimentare
3 Le biotecnologie
Materiali:
Filmati,
lucidi, fotocopie,
carte
geografiche. |
Dalla
rivoluzione industriale ai processi di mondializzazione
1 La robotizzazione
2 Le diverse globalizzazioni
3 Le diverse fasi della riv.
Ind.
4 Mondializzazione e Sud
del mondo
Materiali:
Manuale,
lucidi, fotocopie |
Dalla
memoria alla fiaba.
San
Donato si racconta
Unità di lavoro sull'uso
delle fonti nella ricerca didattica all'interno di un progetto per la realizzazione
di un CD-Rom commissionato dal Comune di San Donato.
In particolare gli studenti
della 2A lavoreranno sulle fonto orali.
Didattica
per progetti
Attività
di laboratorio |
Creazione
di pagine WEB nel sito dell'ITSOS
Creazione di alcune pagine
WEB per descrivere il percorso didattico compiuto realizzando il progetto
Dalla
memoria alla fiaba. San Donato si racconta
Didattica
per progetti
Attività
di laboratorio |
Le ultime due unità
(prevalentemente laboratoriali) si sono svolte lungo il corso di tutto
l’anno scolastico e si sono affiancate (intrecciate) quindi allo svolgimento
delle precedenti.
Alcune
osservazioni relative al lavoro sulle testimonianze
-
Le interviste hanno lo scopo
di presentare, all’interno del CD e sul WEB, da una parte una situazione
antropologico/sociale caratterizzata da una molteplicità di presenze
risultato di successivi flussi migratori, dall’altra di sondare - attraverso
lo strumento della Storia Orale – le principale trasformazioni che il tempo
ha provocato nei costumi, nei modi di vita, sul territorio, a San donato
Milanese.
-
Il primo lavoro è stato
quindi quello di studiare cosa è avvenuto a San Donato nel tempo
(abbiamo scelto come periodo il secolo XX°) e individuare i passaggi
significativi: a tal proposito abbiamo ipotizzato che un punto di osservazione
particolarmente proficuo potesse essere quello relativo all’organizzazione
produttiva e quindi uno snodo strategico potesse essere il passaggio dalla
società agricola a quella industriale e infine a quella postindustriale.
Una volta individuati i momenti più significativi della storia di
San Donato (abbiamo trovato utile lavorare su una semplice, ma esauriente
cronologia) è stato necessario ipotizzare le tipologie dei testimoni
( una mondina? Un operaio? Un impiegato?).
A questo proposito abbiamo
deciso di rispettare i tre seguenti criteri:
-
La variabile di provenienza
(il contadino inurbato dalle campagne sia settentrionali che meridionali
negli anni cinquanta; il meridionale; lo straniero)
-
La variabile di genere (la mondina,
l’operaio, ecc.)
-
La variabile di generazione
(l’anziano, il bambino, l’adolescente, ecc.).
-
Una volta individuata la tipologia
dei testimoni abbiamo provato a strutturare il testo dell’intervista, individuandone
i temi e le problematiche (il lavoro, la scuola, i sentimenti, ecc.) più
in concreto le domande da rivolgere alle nostre fonti.
-
Un momento importante della
ricerca è stata la costituzione dei gruppi di lavoro che, improntati
secondo le tecniche del lavoro collaborativo e attraverso le tre diverse
strategie di scrittura cooperativa (
parallela, sequenziale e reciproca), hanno proceduto ad organizzare
il testo delle interviste.
-
Solo a questo punto della ricerca
è stato possibile procedere con le vere e proprie interviste.
Alcuni
obiettivi
di tipo storico-metodologico
-
Capire quali sono le trasformazioni
di tipo produttivo (economico) e/o politico, che comportano trasformazioni
per quanto riguarda gli insediamenti umani sul territorio e quindi le relazioni
sociali;
-
conoscere i più importanti
problemi originati - per quanto riguarda le relazioni umane e la convivenza
– dai nuovi insediamenti. (Inserimento sul territorio, problemi legati
al lavoro, alla casa, all’essere accettati, al razzismo, alla difficoltà
della lingua, ecc.);
-
saper leggere la relazione tra
flussi demografici e condizioni economiche (è vero che ad ogni trasformazione
produttiva corrisponde un cambiamento demografico? Dall’agricoltura all’industria/dall’industria
al postindustriale/ecc.);
-
conoscere l’importanza delle
fonti per quanto riguarda la ricerca storica;
-
conoscere le prerogative delle
fonti orali e saper individuare domande legittime e significative da porre
ai testimoni stessi;
di
tipo operativo
-
individuare la tipologia dei
testimoni e cercarli;
-
strutturare l’intervista;
-
realizzare le interviste da
inserire nel CD-Rom.
La
ricerca didattica
Il lavoro ha proceduto seguendo
le direttrici fondamentali specifiche di ogni ricerca didattica: in sintesi
le fasi della progettazione sono state cinque:
-
La motivazione, nel nostro
caso, è stata fornita da una parte dalla richiesta di realizzare
un CD-Rom da parte di un committente esterno alla scuola, il Comune
di San Donato, dall’altra dallo spazio WEB – alla voce Ragazzi
all’opera - che la scuola ha messo a disposizione degli studenti. In
questa fase si sono individuate le preconoscenze degli studenti, per individuare
i loro stereotipi e i loro pregiudizi; attraverso la tecnica dei brainstorming
e delle mappe (prima ingenue e poi esperte) si è proceduto a un
serrato confronto tra le diverse ipotesi dei compagni, utilizzando in modo
proficuo il metodo del “conflitto cognitivo” per giungere a formulare un’ipotesi
collettiva di lavoro;
-
Con la messa a fuoco
si sono individuati i temi e i concetti più importanti della ricerca
e si sono stabiliti anche i metodi e le procedure della ricerca stessa
oltre che le fonti da utilizzare. E’ in questa fase che si sono organizzati
i gruppi di lavoro con i rispettivi compiti;
-
Con la fase dell’acquisizione
è iniziata la fase operativa della ricerca: i gruppi di lavoro hanno
reperito documenti, materiali, fonti e strumenti al fine di acquisire il
saper per confermare o smentire le ipotesi di partenza. Questa fase è
forse quella dove maggiormente la ricerca si è configurata attraverso
il laboratorio: laboratorio fisico in senso ristretto, l’aula attrezzata
del laboratorio scolastico, e in senso allargato, il territorio; laboratorio
come spazio mentale in conseguenza del suo essere percorso di ricerca e
del suo approccio metodologico. In questa parte della ricerca si sono effettuate
alcune uscite didattiche: un primo sopraluogo al Comune di San Donato Milanese,
che ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto con la struttura amministrativa
e con i più importanti uffici comunali come l’Ufficio Anagrafe,
l’Archivio, l’Ufficio Stranieri, ecc.; una seconda uscita alla Cascina
Roma ed una terza al Museo di Cultura Materiale, la Cascina Carlotta di
san Giuliano Milanese, dove i ragazzi hanno avuto la possibilità
di lavorare sulle fonti materiali. A più riprese, poi, gli studenti
hanno intrapreso ricerche presso biblioteche ed altri centri di documentazione
(ad esempio l’ISTAT per quanto riguarda i dati relativi all’aspetto demografico).
-
La fase della socializzazione
consiste in un momento importante di sintesi e di verifica del percorso
prima ideato e poi realizzato. E’ questo il momento in cui si è
messa in atto la comunicazione intersoggettiva delle conoscenze acquisite.
Si è cioè chiesto ai diversi gruppi di lavoro di progettare
forme e modi per comunicare quanto “scoperto” lungo la ricerca, per far
emergere ulteriori dubbi e perplessità. In questa fase assume particolare
importanza la visibilità del lavoro sul WEB e la possibilità
di ascolto delle interviste ai testimoni.
-
La fase della verifica
dei risultati acquisiti durante il percorso ha concluso la ricerca. Gli
studenti sono stati invitati ad un’ultima riflessione metacognitiva sul
percorso della ricerca, sui metodi e sulle procedure utilizzate. I ragazzi
trasferiranno il loro prodotto – le interviste ai testimoni e la realizzazione
del WEB – in un altro contesto spazio-temporale, la classe 4 D, che utilizzerà
il loro lavoro all’interno della produzione del CD-Rom.
Ricerca
didattica e museo.
Come già detto questo
lavoro è stato organizzato ad un tempo attraverso il metodo della
ricerca didattica e della didattica per progetti, dall’altro grazie ad
un insegnamento di Storia che ha fatto fortemente ricorso ad attività
di tipo laboratoriali.
Significativa e proficua,
a questo proposito, è stata la visita al Museo di Cultura Materiale
situato presso la Cascina Carlotta di San Giuliano Milanese che,
a mio avviso, è stata una dei momenti più produttivi di tutta
la ricerca didattica.
Il rapporto tra scuola
e museo si è innestato sulla consapevolezza [....] dell’insufficienza
degli strumenti tradizionali di trasmissione del sapere, a partire dalla
lezione “frontale” che nel manuale ha un punto di riferimento preciso(4).
Uscire dal mondo chiuso delle aule scolastiche, aprirsi al contatto diretto
con quel contenitore privilegiato di beni culturali che è il museo,
nel nostro caso un museo di Cultura Materiale, è stato per la 2A
fortemente stimolante: la visita ha avuto molteplici obiettivi, da una
parte è servita come momento di studio in generale sulle fonti materiali,
dall’altra come momento di vera e propria ricerca di documentazione al
fine di organizzare sia il proprio sapere sulla civiltà contadina
degli inizi del ‘900 che la parte più specifica sulle fonti materiali
attinente al WEB.
In questa parte della ricerca
si sono innescati processi di apprendimento attivo e gli oggetti esposti
al museo hanno partecipato a costruire una conoscenza diversa da quella
acquisita tradizionalmente nell’aula scolastica.
La vista è stata
organizzata attorno ad un tema preciso: osservare le trasformazioni che
il tempo (la Storia e gli uomini più precisamente) ha prodotto
nella società contadina della campagna lombarda. Ai ragazzi, ancora
una volta, è stato chiesto di comportarsi come dei piccoli storici,
cioè di compiere in prima persona alcune delle operazioni tipiche
della ricerca storica, sia pure con le necessarie semplificazioni che attengono
all’ambito della didattica piuttosto
che a quello della scienza .
Non ci si è recati
quindi al museo per acquisire nuove conoscenze (o solo per), ma l’obiettivo
principale è stato quello di riuscire a sviluppare strutture di
pensiero autonome (visivo, storico, antropologico, ecc.) attraverso la
consultazione delle fonti materiali lungo le direttrici della ricerca sopra
descritta. In altre parole gli studenti si sono comportati con le fonti
materiali così come hanno fatto con le fonti orali: hanno incominciato
ad interpellarle, hanno cioè individuato quelle domande (le stesse
che si pone lo storico) più significative e legittime per decodificare,
decifrare, il messaggio in potenza nell’oggetto: messaggio naturalmente
non esplicito come quello relativo al testo linguistico, messaggio che
può dare risposte solo se l’interrogazione della fonte è
stata formulata correttamente.
In sintesi le fonti sono
state interrogate al fine di ricevere esaurienti risposte:
-
In relazione alle trasformazioni
per quanto riguarda i processi produttivi e i processi di proprietà;
-
In relazione alle trasformazioni
delle caratteristiche tecnologiche;
-
In relazione alle trasformazioni
delle caratteristiche dei materiali;
-
In relazione alle trasformazioni
dell’organizzazione sociale;
Comunità
d’apprendimento e biblioteca
Una delle raccomandazioni
alla quale giungono per vie diverse il Documento della Commissione dei
“Saggi”, il disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici e il Regolamento
sull’autonomia scolastica, è quella di unire la qualità della
formazione individuale, il successo scolastico e l’innovazione metodologica,
con la predisposizione di ambienti per l’apprendimento al fine di permettere
allo studente di raggiungere il successo scolastico e di acquisire capacità
di autonomia e di giudizio critico.
All’impianto metodologico
è riservata grande attenzione, impianto che deve prevedere, attraverso
una diversificazione di percorsi formativi la creazione di ambienti idonei
all'apprendimento che abbandonino la sequenza tradizionale lezione
- studio individuale - interrogazione per dar vita a comunità
di discenti e docenti impegnati collettivamente nell'analisi e nell'approfondimento
degli oggetti di studio e nella costruzione di saperi condivisi. Queste
comunità dovranno essere caratterizzate dal ricorso a metodi di
insegnamento capaci di valorizzare simultaneamente gli aspetti cognitivi
e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento (5).
Così Roberto Maragliano sintetizza nel Documento dei Saggi il passaggio
dall’insegnare
all’imparare ad apprendere: si suggerisce quindi di costituire
il profilo formativo dello studente attraverso esperienze motivanti e piacevoli,
modi di apprendere gratificanti che lo vedano partecipe e responsabile
in prima persona del proprio processo di apprendimento.
Nel corso della nostra ricerca,
il ricorso alla biblioteca, non solo scolastica, è stato uno strumento
che ha agevolato l’innovazione per quanto riguarda i processi di apprendimento.
La biblioteca, ma in genere qualsiasi centro di documentazione – per antonomasia
ambienti di apprendimento – hanno aiutato a capovolgere il già citato
rapporto lezione-studio-interrogazione e a restituire protagonismo
allo studente nel tentativo di rendersi indipendente lungo il percorso
di acquisizione del sapere, appropriandosi non solo di contenuti, ma di
procedure che gli potessero insegnare a rendersi autonomo e responsabile.
Ancora una volta l’insegnante,
ha abbandonato il suo ruolo direttivo ed ha abbracciato ad un tempo pratiche
di scaffolding cognitivo, attraverso la guida, il sostegno,
la problematizzazione, la consulenza e la critica sull’operato dello studente,
dall’altro procedimenti che hanno fatto ricorso allo scaffolding
affettivo, restituendo motivazione allo studente con il quale si
sono instaurate relazioni sempre meno improntate gerarchicamente e sempre
più fondate su meccanismi di empatia, dove la conoscenza è
sempre più stata co-costruita e dove la realtà è
sempre più stata co-interpretata.
La biblioteca quindi come
vera e propria Comunità d’apprendimento, luogo per
eccellenza che segna il tramonto dell’aula tradizionale e della lezione
frontale, e che trasforma lo studente da ricettore passivo di informazioni
in ricercatore e organizzatore, attraverso i suoi tempi e i suoi stili
cognitivi, del proprio percorso d’apprendimento, luogo dove, in un clima
disteso il sapere viene co-costruito attraverso la sua negoziazione
e la condivisione di procedure e attraverso la riflessione metacognitiva
del percorso di studio e di ricerca.
|