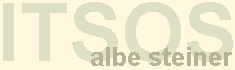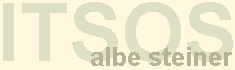Attività
svolta nell'anno scolastico 1999-2000
Classe
II^ C ITSOS "Albe Steiner"
Il lavoro si inserisce all'interno
di un'U.D. sul Nord e il Sud d'Italia che, partendo da una riflessione
su dati statistici relativi alla realtà contemporanea, è
volta a ricostruire storicamente la genesi degli squilibri individuati.
Nel momento in cui il lavoro è stato proposto gli studenti avevano
già affrontato il processo di unificazione nazionale e avevano già
studiato, a livello manualistico, il fenomeno del brigantaggio.
La ricerca si è centrata
in un primo tempo sull'analisi di fotografie di briganti ed è poi
proseguita con la lettura di saggi storici e di alcuni documenti.

Considerazioni
che hanno portato a proporre questa attività
-
l'analisi di immagini fotografiche
si presta ad essere utilizzata come attività-stimolo, per porre
problemi e sollevare domande
-
si tratta di un'attività
più coinvolgente (soprattutto per studenti di biennio) rispetto
all'analisi di documenti scritti
-
il lavoro viene proposto in
un Istituto Tecnico Sperimentale a indirizzo "Comunicazione multimediale"
, in cui la fotografia costituisce un terreno di ricerca particolarmente
adatto
-
il fenomeno del brigantaggio
sembra aver colpito l'immaginario della classe, solitamente poco motivata
alla materia
-
sono facilmente reperibili numerose
fotografie di briganti, anche se le didascalie non forniscono quasi mai
tutte le indicazioni necessarie alla contestualizzazione
Obiettivi
del lavoro
-
imparare a porsi domande a partire
dall'osservazione di immagini fotografiche
-
acquisire consapevolezza della
necessità di integrare le fonti fotografiche con altre fonti (per
rispondere alle domande sollecitate dalle fotografie esaminate)
-
acquisire consapevolezza della
soggettività del punto di vista nella rappresentazione fotografica
-
riflettere sul rapporto tra
evento e rappresentazione fotografica
-
acquisire consapevolezza della
problematicità dell'uso della fotografia come fonte storica
-
saper ricavare da un saggio
storico le informazioni richieste (lettura selettiva)
-
saper prendere appunti e stendere
relazioni sintetiche
Elenco
delle fotografie analizzate (qui andrebbero inserite le foto)
- Tipologie:
-
briganti singoli a mezzo busto;
-
briganti singoli a busto intero;
-
bande o gruppi;
-
brigantesse;
-
briganti fotografati dopo la
morte
- Criteri che hanno
guidato la scelta delle fotografie:
-
varietà all'interno di
ogni tipologia;
-
reperibilità di informazioni
sui soggetti rappresentati;
-
qualità dell'immagine
fotografica
1.1 Il capobrigante Carmine
Crocco Donatelli (D/S)
1.2 Giuseppe Caruso, capobrigante
di Atella. Si costituì nel '63 e ottenne la libertà a patto
di guidare le truppe del generale Pallavicini contro la banda di Crocco
(D)
1.3 Maria Rosa Marinelli.
Brigantessa palermitana della banda Masini, assolta nel processo del 2
maggio 1865; svoltosi nel tribunale di Potenza (T)
1.4 Il "brigante" Tamburini
(E)
1.5 Il brigante Vincenzo
Spinelli di Campagna, fucilato a Salerno (D)
2.1 Il capo Fasanella
catturato (E/S/D/)
2.2 Il brigante Michele
Schirò (D)
2.3 Il capobrigante Gaetano
Manzo di San Cipriano (D)
2.4 Luigi Alonzi, alias
Chiavone (S)
2.5 Il brigante Michele
Caruso, della Capitanata, fotografato nelle carceri di Benevento (1863)
(S)
3.1 La banda Basile
posa per il fotografo (D)
3.2 I fratelli Tannone da
Serravalle (D)
3.3 Gruppo di "briganti"
catturati presso Salerno, nel giugno del 1865 (E)
3.4 Il capobanda Schiavone
e i suoi in catene (D)
3.5 "Briganti" di condizione
civile: i fratelli La Gala. Serie Migliorato. (E)
4.1 Le brigantesse: Reginalda
Cariello (T)
4.2 La più famosa
delle brigantesse, Marianna Oliverio alias Ciccilla, calabrese, fotografata
dopo la cattura (S)
4.3 Maria
Lucia Nella, conpagna di Giuseppe Nicola Somma detto Ninco Nanco (D)
4.4 Michelina
De Cesare compagna di Franceso Guerra (D)
4.5 Filomena
Pennacchio, Giuseppa Vitale e Giovanna Tito della banda di Crocco (D)
5.1 Michelina De Cesare appena
uccisa (D)
5.2 Catturato e ucciso (E)
5.3 Il capobrigante Gaetano
Tranchella fucilato insieme ai suoi luogotenenti (D)
5.4 Il capobanda Nicola
Napolitano detto Caprariello fotografato dopo la morte insieme al suo uccisore
(D)
5.5 Il corpo di Ninco Nanco
esposto al pubblico (D)
S = Salvatore Scarpino, Il
brigantaggio dopo l'unità d'Italia, Milano, Fenice
2000, 1993
D = Aldo De Jaco (a cura
di), Il brigantaggio meridionale,
Roma, Editori Riuniti, 1979
T = Franca Trapani, Le
brigantesse, Editrice Nanni Canesi, Roma s.d., 1968
E = Storia d'Italia, Annali,
2. L'immagine fotografica 1845-1945,
Tomo I, Torino, Einaudi, 1979
Fasi
del lavoro
-
Brain storming sull'idea di
brigante: si chiede a ogni studente di riportare nel centro di un foglio
la parola "brigante" e di collegare ad essa, in ordine sparso, per
associazione di idee, il maggior numero possibile di termini. Alla lavagna
si passa poi da un brain storming individuale uno di classe.
-
La classe si suddivide in gruppi
di 4 o 5 studenti. A ogni gruppo vengono assegnate cinque fotografie da
analizzare (una per ciascuna delle seguenti tipologie: briganti singoli
a mezzo busto; briganti singoli a busto intero; bande o gruppi; brigantesse;
briganti fotografati dopo morti) utilizzando una
scheda
-
Le fotografie analizzate dai
gruppi vengono riesaminate in seduta plenaria, per tipologia ( mezzo busto;
busto intero; gruppi; brigantesse; morti) in modo che sia possibile l'analisi
collettiva delle diverse serie. Gli studenti si dispongono con le sedie
a semicerchio intorno alla lavagna sulla quale sono esposte le fotografie
in modo che siano ben visibili da tutti. Si confrontano le foto di ogni
serie, ci si pongono domande a ruota libera, si fanno ipotesi interpretative,
si discute. Uno studente a turno si offre di compilare una scheda
di analisi per ogni serie, sulla cui base verrà poi stesa una
breve relazione. Poiché il lavoro è piuttosto lungo
e il livello di concentrazione rimane alto per non più di un'ora,
è bene frazionare questa attività in cinque ore separate.
In questa fase è importante che l'insegnante, oltre a guidare la
discussione, faccia emergere gli aspetti problematici dell'uso dell'immagine
fotografica nella ricerca storica (vedi obiettivi).
-
Alla fine si selezionano le
domande più significative per continuare la ricerca attraverso altre
fonti (esempio: come vivevano i briganti? Le brigantesse prendevano parte
ai combattimenti? Perché venivano fotografati dopo morti? Perché
venivano fotografati in posa, armati? ). Il problema è evitare le
domande alle quali non si può ( o comunque risulta molto problematico)
trovare risposte, anche ricorrendo ad altre fonti! Individuate
le domande-tema su cui continuare la ricerca, si riformano
tanti gruppi quante sono le domande, sulla base dell'interesse personale.
-
L'insegnante fornisce testi
scritti (documenti e/o brani di saggi storici) finalizzati a rispondere
alle domande poste dalla classe (vedi bibliografia) . I gruppi esaminano
i materiali e si suddividono i testi da leggere a casa. Ogni studente ha
l'incarico di prendere appunti da un determinato testo. Gli appunti vengono
poi controllati dal docente che verifica così la comprensione e
la capacità di sintesi.
-
Ogni gruppo (utilizzando gli
appunti di tutti i componenti) prepara una scaletta e procede poi alla
stesura di una breve relazione (una o due cartelle) sulla domanda-tema
che le è stata assegnata. Le relazioni, corrette dall'insegnante,
vengono poi ricopiate in word.
-
Un portavoce per ogni gruppo
espone oralmente la relazione ai compagni.

Bibliografia
Informazioni su singoli briganti
e brigantesse
- Tarquinio Majorino, Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997, pp. 169-202 (1)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp.65-87
- Carmine Crocco, Come
divenni brigante, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 1994
- Franca Trapani, Le brigantesse,
Editrice Nanni Canesi, Roma s.d., 1968, pp.53-61(2)
- Salvatore Scarpino, Indietro
Savoia! Briganti nel Sud, Milano, Camunia, 1998, pp.123-133 (3)
- Franca Trapani,
Le
brigantesse, Editrice Nanni Canesi, Roma s.d., 1968, pp.23-33 (4)
- Salvatore Scarpino, Indietro
Savoia! Briganti nel Sud, Milano, Camunia, 1998, pp.75-89 (difficile)
(5)
- Dante Sergio, Il
brigantaggio nell'Italia meridionale nella stampa quotidiana napoletana
1860-1864 in "Archivio Storico delle Province napoletane",1976,
pp. 258-265 ( p. 259 , Parlata di Chiavecone a li napuletane" e Fig. 1,
Pulcinella e lo diavolo zuoppo) (6)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp.269-273
/ illustrazione dopo p. 31, Vita e morte di Chiavone in un foglio di cantastorie
fiorentino (7)
- Salvatore Scarpino, Il
brigantaggio dopo l'unità d'Italia, Milano, Fenice 2000,
1993, pp.58-68 ("Legittimisti e banditi")
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp.244-246
(8)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp.285-300
(9)
- Salvatore Scarpino, Indietro
Savoia! Briganti nel Sud, Milano, Camunia, 1998, pp.107-119 (10)
- Tarquinio Majorino, Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997, pp. 116-121 (11)
- Il Mattino del sabato,
30 giugno 1984 (12)
- Atanasio Mozzillo, Ritratto
di un brigante, in "Nuovo mezzogiorno", gennaio 1986 (13)
- Tarquinio Majorino,
Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997, pp. 249-266 (14)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, illustrazione
dopo p. 272, Connotati di briganti e taglie a disposizione di chi assicurerà
"in qualsiasi modo" alla Giustizia
- Franco Molfese, Storia
del brigantaggio dopo l'unità, Milano, Feltrinelli, 1964,
pp. 383-386 (15)
- Franco Molfese, Storia
del brigantaggio dopo l'unità, Milano, Feltrinelli, 1964,
pp. 307-377 (16)
Possibili
temi di approfondimento
1) Chi erano e come vivevano
i briganti
- Tarquinio Majorino,
Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997 pp.11-15, 110-114 e 91-101 (17) /(11)/(18)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979,pp.40-61
(19)
- Franco Molfese, Storia
del brigantaggio dopo l'unità, Milano, Feltrinelli, 1964,
pp. 307-377 (Elenco delle bande brigantesche attive fra il 1861 e il 1870)
(20)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979,pp.209-210
(26)
- Fonti per la storia
del brigantaggio postunitario conservate nell'Archivio centrale dello Stato.
Tribunali militari straordinari, Ministero per i beni culturali e ambientali.
Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 (28)
2) La fotografia e il
fenomeno del brigantaggio
- Carlo Bertelli, "La fedeltà
incostante", in Storia d'Italia, Annali, 2. L'immagine fotografica
1845-1945, Tomo I, Torino, Einaudi, 1979, pp. 70-72 (21)
- Tarquinio Majorino,
Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997 pp.125-129 (22)
- Salvatore Scarpino, Il
brigantaggio dopo l'unità d'Italia, Milano, Fenice 2000,
1993, pp.34-39
- Ugo Pace, "Raffaele Del
Pozzo fotografo di briganti" in , Johann Jakob Lichtenssteiger, Quattro
mesi fra i briganti (1865/66), Avagliano Editore, Cava dei Tirreni,
1984
3) Le brigantesse
- Tarquinio Majorino,
Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997, pp.340-357 (23)
4) La repressione del
brigantaggio
- Tarquinio Majorino,
Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997, pp.144- 149 (legge Pica) / p. 359-61 (glossario) (24) / (25)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp.302-307
+ bandi (illustrazione prima di p. 145; illustrazioni dopo p. 176); illustrazioni
prima di p. 241) / pp. 152-158 (morte del sergente Romano)
- Aldo de Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp.244-246
- Francesco Gaudioso, Calabria
ribelle. Brigantaggio e sistemi repressivi nel cosentino,
(1860-1870), Milano, Franco Angeli, 1987, pp. 16-17; 28-45; 56-76; 134-147
(29)
Riepilogo
dei testi utilizzati
- Tarquinio Majorino, Storia
e leggende di briganti e brigantesse, Casale Monferrato, Piemme,
1997
- Aldo De Jaco (a cura di),
Il
brigantaggio meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979
- Carmine Crocco, Come
divenni brigante, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 1994
- Franca Trapani, Le
brigantesse, Editrice Nanni Canesi, Roma s.d., 1968
- Salvatore Scarpino, Indietro
Savoia! Briganti nel Sud, Milano, Camunia, 1998
- Dante Sergio, Il
brigantaggio nell'Italia meridionale nella stampa quotidiana napoletana
1860-1864 in "Archivio Storico delle Province napoletane",1976
- Il Mattino del sabato,
30 giugno 1984
- Atanasio Mozzillo, Ritratto
di un brigante, in "Nuovo mezzogiorno", gennaio 1986
- Franco Molfese, Storia
del brigantaggio dopo l'unità, Milano, Feltrinelli, 1964
- Carlo Bertelli, "La fedeltà
incostante", in Storia d'Italia, Annali, 2. L'immagine fotografica
1845-1945, Tomo I, Torino, Einaudi, 1979
- Salvatore Scarpino, Il
brigantaggio dopo l'unità d'Italia, Milano, Fenice 2000,
1993
- Fonti per la storia
del brigantaggio postunitario conservate nell'Archivio centrale dello Stato.
Tribunali militari straordinari, Ministero per i beni culturali e ambientali.
Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 (28)
- Johann Jakob Lichtenssteiger,
Quattro
mesi fra i briganti (1865/66), Avagliano Editore, Cava dei Tirreni,
1984
- Francesco Gaudioso, Calabria
ribelle. Brigantaggio e sistemi repressivi nel cosentino,
(1860-1870), Milano, Franco Angeli, 1987

Prodotti
finali
Prodotto finale del lavoro
sono le relazioni dei gruppi che poi, alternate alle foto e ad alcuni documenti,
verranno esposte in una mostra fotografica all'interno della scuola.
Rispetto al progetto originario
il lavoro è risultato più articolato:
1) I briganti:
a) relazione generale (chi
erano, come vivevano, come combattevano i briganti)
b) brevissime schede informative
su alcuni dei briganti rappresentati nelle foto
c) Carmine Crocco (biografia
di uno dei più famosi briganti)
2) Le brigantesse
a) relazione generale (chi
erano, come vivevano le brigantesse + due esempi di brigantesse delle quali
viene raccontata sinteticamente la storia)
b) brevissime schede informative
su alcune delle brigantesse rappresentate nelle foto
3) La repressione del
brigantaggio
a) Presentazione di due
"casi" di cattura, sulla base di documenti
b) Presentazione della legge
Pica
c) Presentazione di grafici
ricavati da uno studio di storia locale (Cosenza)
4) I sequestri
a) Relazione generale sul
fenomeno, con particolare riferimento a tre sequestri di cui vengono fornite
le coordinate essenziali
b) Intervista alla nonna
di uno studente, il cui bisnonno è stato sequestrato da una banda
di briganti in Lucania negli anni '60
5) La fotografia
Relazione generale sulla
fotografia nel brigantaggio, con riferimento ad alcune foto analizzate
6) La collocazione geografica
del fenomeno
a) carta dell'Italia centro-meridionale
in cui sono indicati tutti i paesi citati nei testi letti dai diversi gruppi
b) carta che illustra le
regioni in cui viene applicata la Legge Pica
|